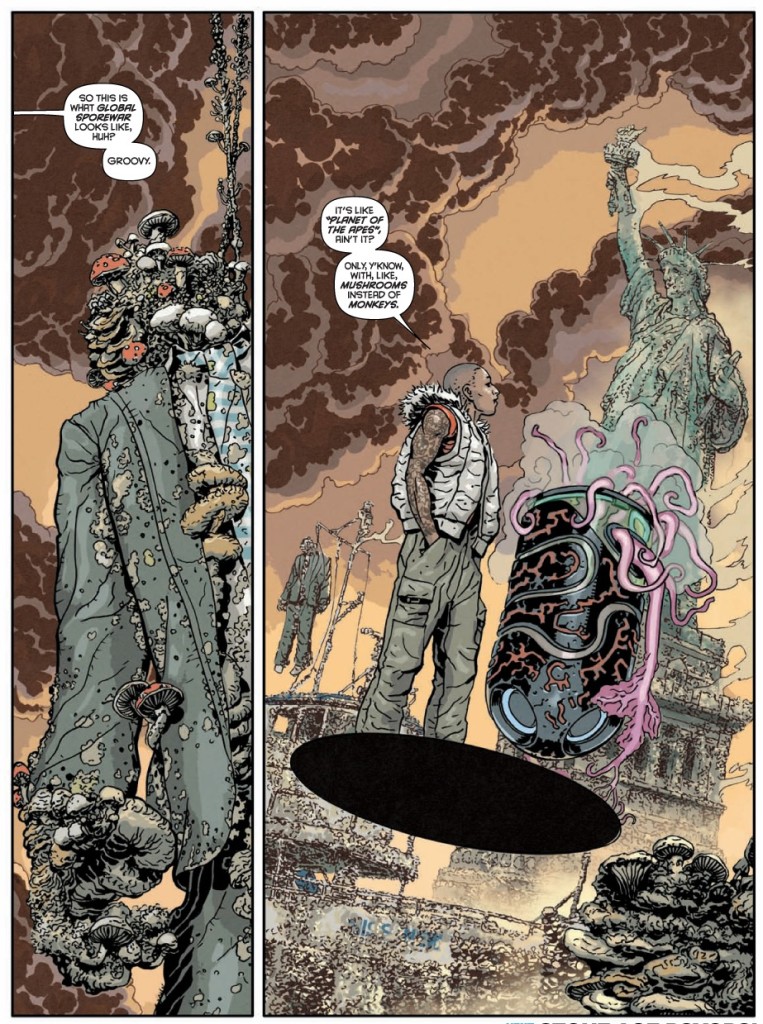Quando hai un nome poco ispirato come il mio, faresti qualunque cosa per farti notare. Anche scrivere fumetti (John Smith)
Ci sono certi autori di cui si parla sempre e comunque, anche a sproposito e anche esagerandone le qualità in maniera inopportuna (fatevi la lista da soli).
Ci sono quelli sfortunati, che meriterebbero il plauso generale e invece rimangono di nicchia (idem).
E poi c’è John Smith, di cui non parla mai nessuno (quantomeno in Italia).
Peccato, perché Smith, classe 1967, è uno degli sceneggiatori britannici di maggior classe di sempre.
D’altronde, è inevitabile che in qualche maniera sia così, visto che in italiano restano inediti, o quantomeno non letti, praticamente tutti i suoi lavori, a parte forse l’immenso Hellblazer 51 (ma ci torniamo).
Il resto della produzione dell’autore inglese si è svolto in massima parte in terra albionica, a parte poche puntate negli USA, tutte incredibilmente sfortunate, e questo, giocoforza, non può che avere un peso in negativo. Eppure, di trofei di cui gloriarsi Smith ne avrebbe eccome: un esordio a diciannove anni su 2000AD (1986), la pubblicazione dei New Statesmen in USA come serie limitata in formato prestige nel 1989 (a ventidue anni!), la creazione di Devlin Waugh, l’unico personaggio capace di detronizzare Judge Dredd nei sondaggi annuali di 2000AD per la miglior serie (1992), Slaughterbowl, l’unica storia della “Summer Offensive” di 2000AD (otto settimane di follia senza controllo) a non esser scritta né da Grant Morrison né da Mark Millar (1993), e via dicendo. Non male per uno sconosciuto, no?
Gli inizi di carriera di Smith, come detto, sono fulminanti. Dopo qualche storia per la DC Thompson, scritta quando non era ancora diciottenne, il nostro arriva ben presto a 2000AD, la storica rivista inglese su cui si sono formati praticamente tutti i più fulgidi talenti britannici. Da subito, il giovanissimo sceneggiatore inizia a impostare quello che poi si è trasformato nello “Smithverse”, ovvero un continuum extra-editoriale in cui i personaggi inventati da Smith si muovono abbastanza liberamente. In particolare, fondamentali in questo costrutto sono i personaggi di Indigo Prime, l’agenzia extra-dimensionale che si dedica al mantenimento dell’armonia del multiverso (inventata in un Future Shock del 1986), che sin dall’inizio rappresenta una sorta di “collante” dell’opera smithiana. A partire da Tyranny Rex (con Steve Dillon, apparsa per la prima volta in 2000 AD 566 del Marzo 1988), propaggini di Indigo Prime si vedranno un po’ dappertutto nei fumetti di Smith, facendo addirittura capolino in una miniserie Vertigo, la sfortunata Scarab.
È a partire dal 1988, con il seminale The New Statesmen, che Smith inizia a far seriamente parlare di sé. The New Statesmen era una serie originariamente presentata su Crisis, una rivista a fumetti “adulta” della Fleetway che, sotto la guida illuminata dell’editor Steve McManus, aveva l’ambizione di voler proporre fumetti maturi e intelligenti per un pubblico che iniziava a stancarsi dell’irrigidimento progressivo di 2000AD. La rivista del celebre Judge Dredd, infatti, aveva messo un po’ da parte l’atteggiamento punk, iconoclasta e irridente degli esordi per diventare un po’ conservatrice.
The New Statesmen, insieme alle altre serie messe in lavorazione per Crisis, era stata programmata per presentare cicli di storie intesi per una successiva raccolta in volume (cosa che effettivamente avvenne per la mini). Creata insieme al disegnatore Jim Baikie, si inseriva nella tradizione della “fiction sociale” tanto radicata nel fumetto inglese, e, per i primi numeri di Crisis, era un perfetto contraltare a World War Three, di Mills ed Ezquerra, fumetto che faceva del taglio realista e dell’analisi delle relazioni razziali i propri punti forti.
L’influenza del seminale Watchmen (che aveva appena finito la pubblicazione in USA, riscuotendo un immediato successo di critica che dura ancora oggi) è palese: The New Statesmen è un thriller politico che nei toni, nelle atmosfere e nello stile (vedi ad esempio la presenza di parti scritte che integrano le pagine a fumetti) parte in maniera decisamente ispirata al capolavoro di Moore-Gibbons. Seppur non eccelsamente originale nelle premesse (siamo sempre nei paraggi del complotto superomistico a sfondo apocalittico), però, il fumetto prende ben presto un’identità propria, e lo fa intelligentemente andando a esplorare quelle aree tematiche in cui Moore, a causa del ferreo controllo sulla trama di Watchmen, non era potuto arrivare, se non di sbieco. Il sottotesto politico, in un mondo di supereroi tanto spaventosi quanto familiari, per Smith diventa un grande canovaccio per esplorare in maniera più estesa e compiuta di Watchmen quelli che poi diventeranno due dei capisaldi della poetica dello sceneggiatore britannico: la sessualità “polimorfa”, il pop e l’horror psicologico. In questo senso, la natura “ultraumana” degli Statesmen e i loro comportamenti scandalosi e irriguardosi di una morale ormai superata dall’evoluzione vanno oltre l’analisi “plot-driven” di Moore, per dipingere un affresco evolutivo che, pur non riuscendo a svincolarsi totalmente dalla pesante eredità dell’opera cardine del “revisionismo supereroistico”, se ne distacca in maniera decisamente fresca in quanto a svolgimento (e perché no, modalità: le pagine scritte di Watchmen diventano qui articoli di giornali scandalistici irresistibili per leggerezza e di libri dalle grandi ambizioni intellettuali).
Al contrario delle allusioni di Watchmen, l’omosessualità (e la polisessualità) dei personaggi di The New Statesmen è esplorata in maniera aperta e fondamentale per l’opera. Oltretutto, prendendo le mosse dall’autocontenuta ucronia watchmeniana, Smith è in grado di mettere in scena un mondo futuristico che supera l’ispirazione originale proprio laddove Watchmen era carente, ovvero nella capacità di catturare lo zeitgeist visuale, lo spirito della moda del tempo, e proporre un futuro credibile. In Watchmen, il pur interessante universo visuale della storia rimane comunque una nota a piè pagina, e per di più piuttosto rigida. Favorito dalla giovane età, invece, Smith, coadiuvato dal disegnatore Jim Baikie ma soprattutto dallo über-mod (all’epoca) Sean Phillips, sublima gli anni ’80 (Phillips, in particolare, si supera in questo senso nell’episodio 5) in una ucronia che deve più a Tamburini e Liberatore che non a Moore e Gibbons. Acconciature e abiti acquistano una patina d’irreale realismo, immortalando per sempre una stagione della moda ormai passata e, allo stesso tempo, per sempre cristallizzata nell’immaginario. Vale la pena ricordare che, ancora oggi, gli esempi riusciti di questo tipo di approccio alla fantascienza non sono tantissimi (vengono in mente Zenith di Morrison-Yeowell e Skreemer di Milligan-Ewins, oltre al Ranxerox dei già citati Tamburini-Liberatore).
Gli Statesmen sono ossessionati dal proprio aspetto, proprio come un superuomo “umano, troppo umano” sarebbe, e questo traspare sempre, in maniera mirata, in ogni pagina. Alcune caratterizzazioni restano troppo sopra le righe o stereotipate (come quella di Vargas, uno Statesman “cattivo” dall’immagine troppo legata a certi cliché evitabili, un laido-violento in stile Comico di Watchmen), è vero. Ma, dal punto di vista visivo, tutto fila: giacche e camicie col collo alla coreana, pantaloni e stivaletti di ispirazione mod, capigliature cotonate e piene di lacca e accessori retro-futuristici riflettono il modo di vestirsi più cool per gli adolescenti della fine degli anni ‘80, e interpretano lo spirito del tempo in maniera molto più compiuta e accurata di quanto avrebbero mai potuto fare due “vecchietti” certamente poco “fashionisti” come Moore e Gibbons.
È in The New Statesmen, inoltre, che Smith inizia a mettere a punto i meccanismi di una costante tensione “esterna” rispetto alla storia. Questa tecnica, incredibilmente efficiente per tenere desta l’attenzione del lettore, sarà poi impiegata con costante frequenza in altre opere durante tutto il corso della carriera dell’autore, con risultati spesso sopra la media.
The New Statesmen, come detto, venne raccolta in volume e presentata anche negli Stati Uniti. Nonostante questo, nell’introduzione l’autore si lamenta del fatto che l’autorevole The Comics Journal (la “Bibbia” della critica fumettistica USA) non ne abbia mai parlato, nonostante il sostegno a Watchmen.
Successivamente a The New Statesmen, John Smith continua a lavorare per il mercato britannico, e, sempre insieme a Sean Phillips e sempre per Crisis, crea Straitgate. In Straitgate, lo sceneggiatore inglese inizia a fare i conti con la censura. La storia, infatti, che doveva rappresentare l’epopea di un giovane allucinato che alla fine commette una strage, viene fortemente ridimensionata, pur mantenendo toni assolutamente disturbanti e disturbati.
Nel 1990, invece, Smith mette a segno un altro colpo magistrale, creando Devlin Waugh, l’esorcista numero uno di Vatican City (una delle MegaCity di cui è composto l’universo di Judge Dredd). Waugh è uno dei personaggi più riusciti della carriera dell’autore e un “fan favourite” di lunga data.
Già dalla prima storia (Swimming in Blood), in Devlin Waugh Smith riesce a riversare con naturalezza i propri punti forti: dialoghi magistrali, la capacità di riplasmare il pop nelle sue varie forme, l’analisi della sessualità “alternativa”, l’horror, la psichedelia “magica”.
In maniera simile a quanto fatto con Sebastian O dal conterraneo Grant Morrison (con cui condivide l’approccio di base per quanto riguarda la scrittura), Smith utilizza la figura del dandy come antidoto al “grim and gritty” tanto di moda in quel periodo. E lo fa in maniera azzeccatissima, sin dal primo momento in cui il personaggio appare (“The name’s Waugh. Devlin Waugh. I’m here to steal the show…”).
Waugh è, sin dal nome (un gioco di parole con Evelyn Waugh, scrittore satirico e fondamentalista cattolico) e dall’aspetto (Terry-Thomas con il fisico di Arnold Schwarzenegger), totalmente sopra le righe. Smith si propone di creare un nuovo tipo di eroe, che non ha forti motivazioni (come invece i classici Judge Dredd o Rogue Trooper) ma, in puro spirito “pop”, agisce per esorcizzare uno spaventoso senso di noia da dandy (l’ennui di Oscar Wilde).
Waugh è il primo eroe britannico dichiaratamente omosessuale (campione olimpico di arrangiamento di fiori?), e l’autore si giova di questa caratteristica nel modo migliore, sia a livello iconografico che narrativo. In maniera alternativa a Judge Dredd, il personaggio di Devlin Waugh è perfetto per esplorare sfumature altre rispetto ai bassifondi infestati da “perp” che caratterizzano le MegaCity dei Giudici. La tagliente sagacia, le oltraggiose abitudini e l’eccessiva eleganza di Devlin Waugh sono fattori “camp” che fanno da controcanto alle storie a sfondo horror in cui Waugh viene catapultato dall’autore. Infatti, la prima avventura dell’esorcista gay, Swimming in Blood, lo vede subito trasformato in vampiro dopo una terrificante odissea ad Aquatraz, penitenziario di massima sicurezza in cui i psicopatici vampiri marini prigionieri iniziano una sanguinosa rivolta.
Come detto, Swimming in Blood, disegnata da uno Sean Phillips “pittorico” in forma stratosferica, vale al personaggio il plauso del pubblico, che lo incorona come più amato dai lettori fra quelli del parco di 2000AD nel 1992.
Il successivo “breve incontro” di Waugh con il peso massimo Dredd (che si conclude in un sostanziale pareggio) ne cementa la reputazione e fa salire le azioni di Smith.
Sembrano tutte rose e fiori: la carriera dello scrittore pare destinata a decollare, soprattutto in vista della nascita della sottoetichetta per adulti della DC Comics, la Vertigo, che scippa (una volta per sempre, in molti casi) gli sceneggiatori di punta della scena britannica. E invece arriva un brusco stop.
Il profilo dell’autore, che sembrava destinato a seguire le orme di Moore e degli epigoni Gaiman, Morrison e Milligan per diventare l’ennesima superstar britannica della sceneggiatura, entra invece in fase di stallo. Varie vicissitudini (leggi: una serie di sfighe abissali) impediscono al Nostro di raggiungere quel potenziale che viene fuori in maniera inequivocabile leggendo le sue storie, anche quelle meno riuscite.
Le cose sembrano implodere nel 1993, l’anno in cui Smith scrive il suo primo (e unico) Hellblazer.
A detta di Smith, dopo anni che lo scrittore si era proposto come successore di Jamie Delano (una specie di “playoff” con altri due scrittori in ascesa, Warren Ellis e Garth Ennis, colui che poi ottenne il posto), a un certo punto ricevette la fatidica telefonata da Karen Berger, che gli chiedeva se gli andasse di realizzare un numero riempitivo.
E così nasce Counting to Ten.
C’è chi lo definisce il migliore numero di sempre, e non sembra solo una boutade. Qui il controllo di Smith sull’horror psicologico è totale. Usando tecniche mutuate più da Ramsey Campbell e Clive Barker che da Alan Moore (e il succitato Delano), Smith “sposta” l’orrore fuori dalla storia, facendoci intuire un mondo di angoscia incomunicabile (quella che fa quasi perdere il senno a Costantine) al di là delle pagine del fumetto, e lo fa senza darci spiegazioni definitive o forzarci in alcuna direzione. Aiutato dal fascino naïf e impressionista di un Sean Phillips pre-ossessione fotografica, in sole 24 pagine John Smith è capace di caratterizzare nella maniera più compiuta tutti i tratti principali di John Costantine, compreso il senso di totale “inglesità” che aveva caratterizzato il ciclo di Delano. Allo stesso tempo, però, con grande consapevolezza e molta faccia tosta (altre caratteristiche precipue dello sceneggiatore), Smith si impone subito come innovatore. Inizia la storia come una brutta barzelletta, sia in didascalia (“So there I was…”) che visivamente (un inglese entra in lavanderia…) e, in modo totalmente naturale, si permette di svelare subito, una volta per sempre e in maniera inoppugnabile, la bisessualità di John Costantine. A livello di sceneggiatura, i dialoghi e le didascalie (io interiore) plasmano il personaggio, aggirando dall’inizio in maniera decisa il cliché di “English bastard” monodimensionale su cui tanti sceneggiatori (alcuni anche bene o molto bene) si sono basati.
Usando una griglia ad alto numero di vignette, da cui si esce solo all’inizio e alla fine con splash page che dilatano i tempi narrativi, lo sceneggiatore è in grado di costruire una storia assolutamente statica, dove la tensione monta in maniera crescente solo grazie alla capacità di comunicare l’ineffabile (anche grazie ai ficcanti primi piani di Sean Phillips, in grado di aggiungere quell’atmosfera sporca e deprimente che fa da catalizzatore alle ossessioni più profonde di Costantine – e del lettore). Come qualcuno ha fatto giustamente notare, nelle mani di altri sceneggiatori, le ambiguità che rendono la storia un trionfo sarebbero state probabilmente evitate tramite un trattamento “verticale” (leggi: c’è una minaccia e John la affronta). Ma Smith non sembra accontentarsi di un tale mezzuccio, e opta per soluzioni molto più spaventose e meno accademiche. La trivialità dell’orrore (mai come questo caso horror vacui), che l’autore era andato elaborando fino ad allora e che raggiungerà vertici ulteriori negli anni della maturità, inizia a prendere corpo in maniera diretta, iniziando al contempo a porre le basi per quell’approccio “sensoriale” all’horror che caratterizza da sempre la scrittura di Smith.
La resa è un trionfo. Non sappiamo come fu accolto Hellblazer 51 in Vertigo (è facile presagire in maniera freddina: Smith menziona in una intervista il pettegolezzo che Karen Berger odiasse il suo stile), ma è un biglietto da visita che gli vale la ribalta di una serie regolare per il neonato imprint della DC. Il trionfo, però si tramuta subito nel fiasco più colossale, e forse la ragione principale della mancata carriera di Smith al di là dei confini natii: Scarab.
(end of part one. La seconda parte è qui.)